HOME
Pubblicato in APPUNTI gennaio 202
Reati di opinione
english versione
Giovanni De Sio Cesari
www.giovannidesio.it
 È
un principio universalmente accettato che, dal punto di vista legale, ognuno
possa fare ogni cosa che desidera a meno che non sia vietato espressamente dalla
legge o anche previsto come obbligatorio dalla legge. Non sono libero di passare
con il rosso al semaforo e non posso lasciare un ferito senza soccorso. Un tale
principio non vale solo nelle democrazie ma in qualsiasi altra forma di
governo, nel presente come nel passato, anche se in regime democratico si tende
ad allargare, ma non sempre, la sfera delle libertà di azione del cittadino.
È
un principio universalmente accettato che, dal punto di vista legale, ognuno
possa fare ogni cosa che desidera a meno che non sia vietato espressamente dalla
legge o anche previsto come obbligatorio dalla legge. Non sono libero di passare
con il rosso al semaforo e non posso lasciare un ferito senza soccorso. Un tale
principio non vale solo nelle democrazie ma in qualsiasi altra forma di
governo, nel presente come nel passato, anche se in regime democratico si tende
ad allargare, ma non sempre, la sfera delle libertà di azione del cittadino.
Quello che invece caratterizza le democrazie è che il pensiero è libero,
soprattutto è libera la sua diffusione, per cui ciascuno può non solo pensare
quello che crede (sarebbe impossibile vietarlo), ma anche esprimere il suo
pensiero. Quindi, vi è anche una ampia libertà dei mezzi di informazione, che si
è ampliata enormemente con la diffusione del web.
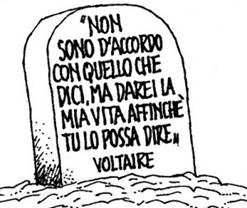 Tuttavia,
anche nei regimi democratici esistono, anche se non denominati come tali, reati
di opinione. In genere vengono etichettati come istigazioni all’odio o alle
discriminazioni nel presupposto che siano in qualche modo contrari ai principi
costituzionali.
Tuttavia,
anche nei regimi democratici esistono, anche se non denominati come tali, reati
di opinione. In genere vengono etichettati come istigazioni all’odio o alle
discriminazioni nel presupposto che siano in qualche modo contrari ai principi
costituzionali.
Ma esaminiamo la questione.
Mi pare che tali reati siano in contrasto con le libertà democratiche. Certo, le
leggi possono vietare di fare discriminazioni razziali e sessuali: quindi non
posso escludere omosessuali e neri dalle assunzioni se ho un'impresa (in realtà
posso farlo lo stesso
con un'altra
scusa).
Ma io penso che se esiste libertà di opinioni non possiamo vietare le opinioni
contrarie a quelle prevalenti, anche in ambito razziale e di genere: sarebbe un
fascismo alla rovescia, come si dice.
Mi sembra anche contraddittorio che una legge vieti il diffondere una certa
idea contraria. Le leggi, infatti, possono essere abrogate (esiste anche un
referendum). Ora, se una legge vieta la diffusione dell’idea contraria, allora
non sarebbe più possibile, in effetti, abrogarla. Non sarebbe più una legge
statale connessa a una cultura sempre variabile, ma sarebbe una legge divina
immutabile nell’eternità. Lo stesso discorso si  può
fare anche con la Costituzione: anch’essa è frutto della cultura prevalente in
un certo momento storico e può essere modificata secondo procedure che la stessa
Costituzione prevede. Mi pare del tutto arbitrario stabilire che alcuni dei suoi
articoli siano invece intoccabili e non modificabili come una legge divina, e
altri invece lo siano.
può
fare anche con la Costituzione: anch’essa è frutto della cultura prevalente in
un certo momento storico e può essere modificata secondo procedure che la stessa
Costituzione prevede. Mi pare del tutto arbitrario stabilire che alcuni dei suoi
articoli siano invece intoccabili e non modificabili come una legge divina, e
altri invece lo siano.
Se la maggioranza pensa che X sia cosa giusta non significa affatto che X sia
cosa giusta: è presupposto essenziale della democrazia che si abbiano opinioni
contrarie che potrebbero, in un certo momento, prevalere. È l’essenza stessa
della democrazia. Non è che la libertà di pensiero significhi uniformarsi a una
verità ufficiale.
Ad esempio, in alcuni Stati è diventato reato il negazionismo della Shoah, che
viene assimilato alla giustificazione della Shoah stessa. Ma è in palese
contraddizione che chi ritiene che la Shoah non sia mai avvenuta (a torto o
ragione, non importa) possa poi essere incolpato di giustificare un fatto che
ritiene mai avvenuto. Ma il problema della negazione della Shoah è un caso
particolare che qui non approfondiamo.
Facciamo alcuni esempi più comuni.
Se io penso che i neri siano meno intelligenti dei bianchi o che
l'omosessualità sia un vizio pericoloso o che le donne abbiano attitudini e
ruoli diversi dagli uomini, devo poterlo dire?
 In
passato, si riteneva che i neri fossero una razza inferiore e l'omosessualità
una degenerazione pericolosa per la società, mentre modernamente invece prevale
l’idea dell’uguaglianza delle capacità e dell'
omosessualità come una variante della sessualità. Analogamente, oggi si è
concordi nel fatto che donne e uomini possano aspirare agli stessi ruoli, tranne
specifiche limitazioni che comunque vengono ammesse (ad esempio nell’ambito
dello spettacolo) e che in realtà sono molto più ampie di quanto poi le leggi
ammettano; ad esempio, è ben difficile che si assuma un uomo come collaboratore
domestico così come è alquanto improbabile che una donna venga assunta come
bodyguard.
In
passato, si riteneva che i neri fossero una razza inferiore e l'omosessualità
una degenerazione pericolosa per la società, mentre modernamente invece prevale
l’idea dell’uguaglianza delle capacità e dell'
omosessualità come una variante della sessualità. Analogamente, oggi si è
concordi nel fatto che donne e uomini possano aspirare agli stessi ruoli, tranne
specifiche limitazioni che comunque vengono ammesse (ad esempio nell’ambito
dello spettacolo) e che in realtà sono molto più ampie di quanto poi le leggi
ammettano; ad esempio, è ben difficile che si assuma un uomo come collaboratore
domestico così come è alquanto improbabile che una donna venga assunta come
bodyguard.
Non possiamo ignorare che per millenni in tutte le civiltà i ruoli maschili e
femminili erano rigidamente distinti secondo le culture del tempo, e nulla ci
deve vietare di pensare che esse debbano essere invece tutte uniformate (cosa
che peraltro non avviene nemmeno oggi).
La democrazia proclama la parità di diritti per le minoranze, ma per queste si
intendono minoranze etniche, linguistiche, religiose. Ma non rientrano in queste
categorie, ad esempio, le differenze fra uomini e donne o dell’omosessualità:
infatti per secoli anche le democrazie hanno ammesso l’autorità del marito
sulla moglie e hanno considerato l'omosessualità una degenerazione pericolosa
per la società, mentre attualmente si è affermata l'idea che si tratti di una
semplice variante che comunque non danneggia la società.
È mutata la concezione che si aveva un tempo della donna e dell'omosessualità,
ma questo non c’entra molto con la democrazia. A riprova, nel mondo antico la
democrazia come la intendiamo noi era in effetti sconosciuta, ma spesso
l'omosessualità era accettata (anche praticata da grandi pensatori e da grandi
imperatori).
Si pretende in sostanza che solo le idee ora preminenti e più in voga siano le
uniche vere e giuste, e che quelle che, anche se vagamente, dissentano, siano
false e cattive, il che è contrario alla libertà di pensiero, essenza della
modernità.
In conclusione, direi che la pretesa di verità assoluta e definitiva è in
contrasto con la cultura moderna, che le rifiuta anche nella scienza.
Il problema è che alcuni non si sentono più liberi di esporre le proprie
opinioni perché c'è come un Grande Fratello, una autoproclamata autorità che
vuole imporre una uniformità di pensiero che in realtà poi non esiste nella
realtà.
Intendo però chiarire con forza che non si vuole in questa sede in nessun modo e
sotto nessun aspetto sostenere il razzismo, l'omofobia o negare l'uguaglianza di
genere, ma solo sostenere il diritto di esprimere anche idee contrarie a tali
indirizzi.
Inizio modulo
Fine modulo
diverso, più che altro uno dei tanti quartieri dormitori che circondano le
grandi città, molto diversi dai vicoli effervescenti di vita della città
vecchia.
Ho rivisto quando si fumava continuamente, c’era chi accendeva la sigaretta su
quella che stava spegnendosi.
Alla
scuola elementare si andava con i grembiuli neri, le penne con i pennini
cavallotti che si intingevano nella boccetta di inchiostro.
E poi si vedono i ragazzi del liceo in giacca e cravatta, e le alunne con i
grembiuli neri senza tacchetti, e i professori che davano del “lei” agli alunni:
come mai uno dei liceali di oggi potrebbe immaginare comportamenti del genere!
Si vede
poi l’esplodere della contestazione giovanile, e quindi del femminismo e poi
degli “anni di piombo” – come poi furono detti – con l’entusiasmo giovanile e
l’illusione di rinnovare dalle radici tutto il mondo ormai vecchio e corrotto.
Pura illusione di un tempo passato; e poi il lento riflusso fino ad arrivare a
Tangentopoli.
Notevoli le ricostruzioni dei luoghi, come Piazza del Plebiscito percorsa dalle
auto di allora: le modeste 600 e le 1100, roba da ricchi. E quindi gli abiti e
le toilette, gli uomini con il cappello, le ragazze dalle gonne ampie e lunghe.
E le prime vacanze modeste ed economiche in case affittate a Ischia, con gli
ombrelloni portati da casa.
Certo,
la ricostruzione storica ha fatto rivivere quegli anni ormai lontani a chi li ha
vissuti e li fa conoscere a chi poi non riesce nemmeno a immaginarli. Tuttavia,
se i particolari sono resi in modo davvero preciso storicamente, non mi sembra
che lo stesso si possa dire del comportamento delle ragazze degli anni ’50, che
ne sono le protagoniste.
Pensiamo, ad esempio, al matrimonio di Lila, che avviene intorno ai 16 anni.
Negli anni ’50 un matrimonio prima dei 18 o 20 anni avveniva solo se si fosse
trattato di uno di quelli che allora era definito “riparatore”: i due giovani
avevano fatto sesso e concepito un figlio (combinato il guaio) e quindi erano
tenuti a riparare unendosi in matrimonio.
Qui invece vediamo una ragazza sui quindici anni, spinta al matrimonio con un
giovane che non vuole e che, con grande abilità, riesce invece a farsi sposare
da un altro.
Soprattutto, l’atteggiamento di Lenù, che diverrà poi la scrittrice, non è certo
consono allo spirito degli anni ’50. In quel tempo, le ragazze più spinte si
lasciavano toccare e palpeggiare dai fidanzati e magari qualcosa di più, ma
comunque erano ben accorte nel proteggere la propria verginità. Se non per un
principio etico, almeno per il semplice fatto che perdere la verginità avrebbe
significato grande difficoltà di essere accettate dai ragazzi come spose. In
quel tempo il bianco dell’abito nuziale non era una semplice moda, ma il segno
di uno stato reale di purezza, come si diceva.
Tutto
questo non escludeva che le ragazze potessero perdere la propria verginità,
magari travolte in un momento di passione insieme ai loro ragazzi o magari
spinte da questi con abilità e inganno (sedotte e abbandonate, come si diceva).
Nella
serie TV vediamo invece Lenù, frustrata per non poter realizzare un amore
sognato dall’infanzia, che chiede apertamente di fare sesso completo per la
prima volta con un uomo anziano, verso il quale provava più che altro ribrezzo,
perché qualche anno prima aveva allungato le sue mani sulla sua intimità. Come è
pensabile che una ragazza degli anni ’50 si comporti in modo cosi disinvolto?
Nel
seguito, ella ha poi rapporti con due altri fidanzati come se fosse cosa del
tutto normale, come potrebbe avvenire in tempi recenti. Incontra poi quello che
sarà suo marito, il quale rigetta la sua disponibilità a fare sesso
prematrimoniale, aspettando pazientemente le
 nozze. Pure qui ci si chiede: se un
giovane tiene al principio della purezza verginale della sposa, come mai si
innamora di una che quella purezza ha sempre rifiutata e che continua a
rifiutare?
nozze. Pure qui ci si chiede: se un
giovane tiene al principio della purezza verginale della sposa, come mai si
innamora di una che quella purezza ha sempre rifiutata e che continua a
rifiutare?
Nel
seguito poi della vicenda, Lenù tradirà il marito spudoratamente nella stessa
casa matrimoniale: una notte esce dal letto del marito e si infila in quello di
un altro, fa sesso con lui perfino nel bagno, con il marito fuori, che poi
lascerà con le figlie. Ma questa vicenda può manifestarsi in ogni epoca, perché
comunque riprovata universalmente.
Altro
elemento poco realistico storicamente sono le figure dei fratelli Solara,
considerati i boss del rione, anche se non è poi chiaro quali siano i loro
crimini.
Il
camorrista, il capo mafia, è persona calma, fredda e che pondera con lucidità e
prudenza le sue azioni. Tale, all’inizio del racconto, si mostra Don Achille, il
capo camorrista precedente: quando le due bimbe lo accusano di aver rubato loro
le bambole, egli, non comprendendo bene cosa vogliano dire, dà loro del denaro
perché ne comprino un’altra: un gesto accorto da capo mafia. Invece, i fratelli
Solara, in particolare uno di essi, sono estremamente collerici, violenti,
pronti a picchiare violentemente – con il rischio di uccidere – chiunque li
indisponga. Ma questo modo di agire è tipico degli scagnozzi, degli esecutori di
violenze gratuite, non certo di quelli che governano la malavita, riuscendo ad
arricchirsi con essa.

 È
un principio universalmente accettato che, dal punto di vista legale, ognuno
possa fare ogni cosa che desidera a meno che non sia vietato espressamente dalla
legge o anche previsto come obbligatorio dalla legge. Non sono libero di passare
con il rosso al semaforo e non posso lasciare un ferito senza soccorso. Un tale
principio non vale solo nelle democrazie ma in qualsiasi altra forma di
governo, nel presente come nel passato, anche se in regime democratico si tende
ad allargare, ma non sempre, la sfera delle libertà di azione del cittadino.
È
un principio universalmente accettato che, dal punto di vista legale, ognuno
possa fare ogni cosa che desidera a meno che non sia vietato espressamente dalla
legge o anche previsto come obbligatorio dalla legge. Non sono libero di passare
con il rosso al semaforo e non posso lasciare un ferito senza soccorso. Un tale
principio non vale solo nelle democrazie ma in qualsiasi altra forma di
governo, nel presente come nel passato, anche se in regime democratico si tende
ad allargare, ma non sempre, la sfera delle libertà di azione del cittadino.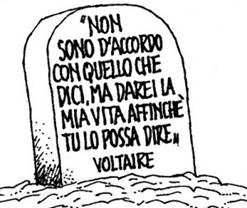



 nozze. Pure qui ci si chiede: se un
giovane tiene al principio della purezza verginale della sposa, come mai si
innamora di una che quella purezza ha sempre rifiutata e che continua a
rifiutare?
nozze. Pure qui ci si chiede: se un
giovane tiene al principio della purezza verginale della sposa, come mai si
innamora di una che quella purezza ha sempre rifiutata e che continua a
rifiutare?